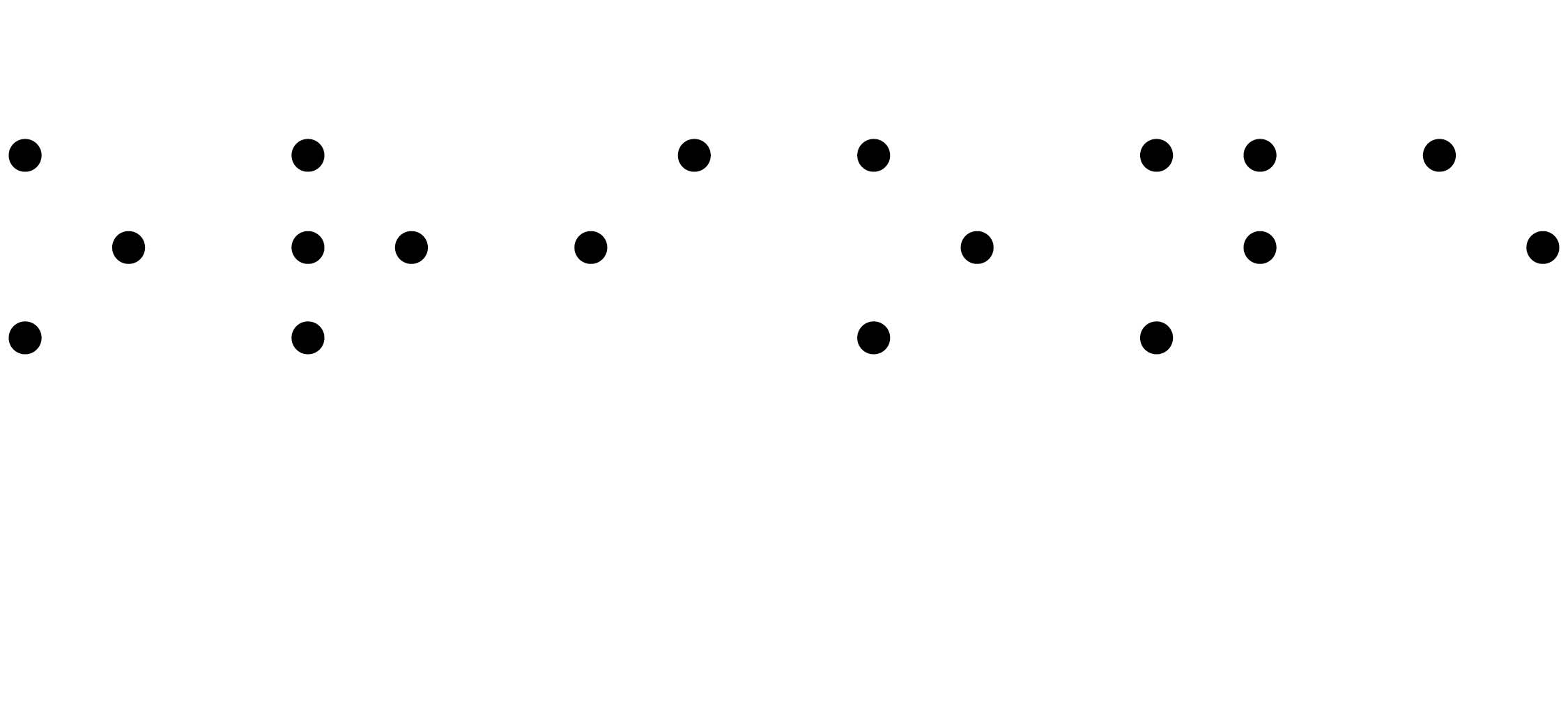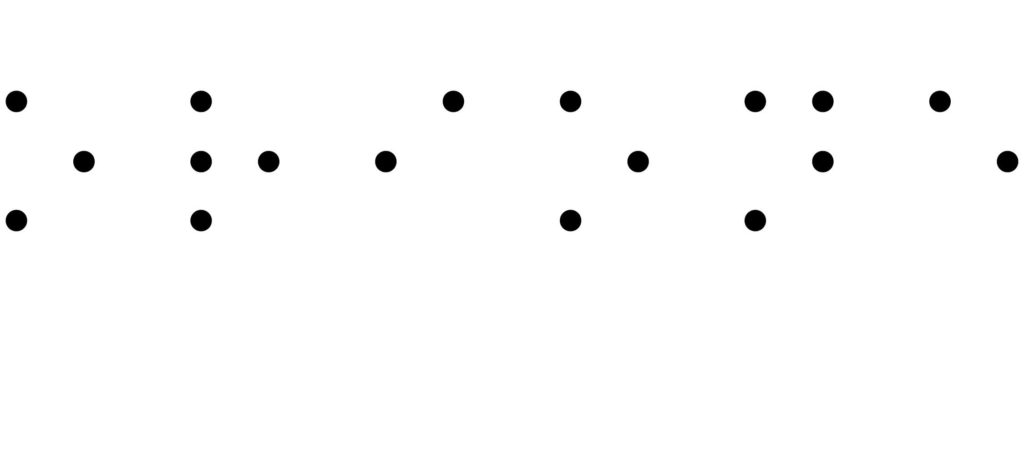Non è possibile un lavoro senza che sia implicato un soggetto che, in modo più o meno appassionato, giochi se stesso in questo particolare rapporto con la realtà che si chiama attività lavorativa. Questa premessa, tra l’altro, è così evidente nella storia di molte organizzazioni, anche le più complesse dove, con buona pace di coloro che in seguito avrebbero avuto responsabilità gestionali, non sarebbe accaduto nulla se non vi fosse stata una persona che avesse esposto con grande determinazione il proprio “io”. Credo che questa determinazione nel giocare se stesso, con tutti i rischi e le responsabilità che essa suscita, può avere due origini: la prima è basata sulla presunzione di proporre se stesso come l’unico protagonista in grado di indicare soluzioni originali e di controllarne lo sviluppo e l’affermazione. La seconda origine, che è di gran lunga la più interessante, è una responsabilità che la persona si sente di assumere perché affida la propria azione ad una sorta di ipotesi positiva. Questa è una posizione esistenziale che non si lascia facilmente corrompere dalle contingenze negative, anche le più subdole.
LA TENTAZIONE DELL’UTOPIA
Secondo la mia esperienza, la persona che decide di giocarsi responsabilmente nel lavoro, raramente si lascia lungamente permanere nella prima delle due condizioni. La realtà è così complessa e testarda che è praticamente impossibile rimanere per molto in un atteggiamento arrogante senza suscitare un senso di inadeguatezza, di tristezza e, alla fine, anche di ridicolo. Tutti sanno che, alla lunga, la combinazione di queste caratteristiche porta alla solitudine. È certamente più vero il fatto che le grandi personalità del mondo del lavoro, dai grandi imprenditori ai grandi fondatori di opere, hanno sempre avuto un grande carisma nella capacità di coinvolgimento partecipativo. Tutti, in modo più o meno consapevole, sono stati guidati da una ipotesi positiva che certamente ha dato a loro la capacità di superare un atteggiamento autoreferenziale e di affrontare la realtà coinvolgendo in modo adeguato le persone di cui si erano attorniati. Ma che cos’è questa ipotesi positiva senza la quale nel lavoro si diventa o irresponsabili, per pigrizia o per indifferenza, o onnipotenti, per arroganza o incoscienza? Come è capitato a molte persone della mia generazione, questa ipotesi positiva si è spesso cristallizzata in una posizione ideologica: una posizione assolutamente impermeabile agli insegnamenti dell’esperienza ma incline a proporre e a perpetuare soluzioni preconfezionate. C’è stato un momento in cui tutto doveva essere giudicato subito e senza appello: la scuola non funziona, cambiamola! Il lavoro ci aliena, cambiamolo! La famiglia ci soffoca, cambiamola! La società ci opprime, cambiamola! La vita ci lascia insoddisfatti, cambiamola! Si diceva che dovevamo cambiare tutto, con le parole di Bob Dylan si cantava: [1]
Don’t stand in the doorway.
Don’t block up the hall.
For he that gets hurt
Will be he who has stalled!
There’s a battle outside.
And it is ragin’.
It’ll soon shake your windows.
And rattle your walls
For the times they are a-changin’.
Questa insoddisfazione generale non suscitava altro che rabbia e frustrazione anche perché il passaggio successivo è stato quello dell’affermazione dei diritti: la salute è un diritto, l’educazione è un diritto, l’occupazione è un diritto, la socialità è un diritto, e l’accoglienza, la condivisione, l’amicizia e su fino al grande diritto alla verità. Pensate al significato di questa potente e positiva ipotesi di confondere il diritto con il dato. Quanta energia e creatività ma anche quante pretese, quante contraddizioni, quante illusioni e quindi quanta collera. Create da quello che in sintesi si può definire una utopia. Come ci diceva un grande educatore come Luigi Giussani: «L’utopia è una tentazione. La tentazione di riporre la speranza, la dignità e la fatica in un progetto astratto, in un discorso, in una soluzione puramente organizzativa». [2] Ma perché storicamente l’utopia si afferma? Perché lavorando — e in particolare quando ci convinciamo di lavorare bene, cediamo all’illusione di poter realizzare una cosa bella e giusta, cioè perfetta, che prescinda dal fatto che noi non siamo perfetti. Che noi non siamo completi. L’utopia ci inchioda a dei sogni ideali e irraggiungibili evitando, così, di affrontare in modo concreto i problemi della vita su un piano reale. Ricordo che, visitando uno dei progetti di cooperazione (nel passato mi sono occupato di progetti di cooperazione internazionale), un cooperante mi ha detto una cosa impressionante per la coscienza e la sofferenza di come è stata pronunciata: «Io non sarò mai felice, perché sono perfezionista in un mondo che perfetto non è». Prigionieri di una utopia, quella di considerarsi completi in un corpo e una realtà che completa non è. Una utopia che alla prova del tempo e dell’imperfezione (stanchezza, distrazione e oggettive difficoltà di gestione), oltre al disastro della delusione e della pretesa, conduce anche a un ritiro della responsabilità e della libertà personale. Si nega la possibilità di giocare il proprio io e si privilegia la regola e il ruolo che diventano gli unici fattori in campo.
L’IPOTESI POSITIVA COME ESPERIENZA RAGIONEVOLE
Ma allora su cosa deve fondarsi questa ipotesi positiva per evitare che diventi un motore ideologico e astratto? Emmanuel Mounier suggerisce una interessante riflessione: «È dalla terra, dalla solidità che deriva necessariamente un parto pieno di gioia e il sentimento paziente dell’opera che cresce, delle tappe che si susseguono, aspettate quasi con calma, con sicurezza. Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina ma nasca dalla carne». [3] Ecco, questa affermazione mi dà la forza di dire che è dalla nostra carne che deve venire la positività di mettere in pista la propria responsabilità, la propria libertà e, quindi il proprio io. E cosa ci dice la carne? Ci dice che possiamo lavorare solo se avvertiamo una corrispondenza tra la nostra natura, fatta di intelligenza e affettività e la realtà che, lavorando, si pone di fronte. Ragione e affetto devono sentirsi sollecitati fino in fondo senza temere di sentirsi inadeguati. E, in fondo, se siamo sinceri con noi stessi, non possiamo accettare qualcosa di meno. Questa posizione, che sembra ci obblighi a incatenare la nostra intimità con un contesto di lavoro spesso percepito come un elemento estraneo, viceversa ci libera definitivamente dal dualismo di una vita spezzata tra il lavoro (cioè il posto di lavoro) e l’esistenza individuale e ci conduce a una unitarietà pacificante finalmente non fondata su un’idea astratta ma su una esperienza reale. Berthold Brecht, in una sua poesia ci dice, da par suo, come il lavoro nasca spesso da una responsabilità più grande che abbiamo liberamente assunto su di noi:
In me si scontrano
l’entusiasmo per il melo in fiore
e l’orrore per i discorsi dell’imbianchino
solo il secondo però
mi spinge di forza al tavolo di lavoro.4
È pur vero che per chi, come il sottoscritto, lavora in una organizzazione complessa, non c’è niente di più rischioso e affascinante che trascinare la propria identità all’aperta e franca verifica con la realtà circostante. Mentre questo non è possibile per un soggetto che, proprio per la sua natura, vuole e deve essere assolutamente neutro e asessuato, quasi estraneo all’ambiente nel quel lavora, l’avventura della verifica può avvenire solo se diventa chiaro il significato del proprio lavoro anche dentro una realtà frammentata. Famosa è la storiella dei due operai russi impegnati entrambi a trasportare dei pesanti e voluminosi frammenti di marmo. Di fronte alla persona che chiedeva cosa stessero facendo, i due operai rispondevano in due modi completamente diversi: il primo stava «trasportando dei dannati pezzi di marmo». Il secondo stava «partecipando alla costruzione di una cattedrale». Se messo in condizioni di percepire il significato del proprio lavoro, il singolo uomo all’opera non ha difficoltà a capire cosa gli è chiesto anche se il compito a lui assegnato sia particolarmente esigente e gravoso. Nel lavoro dell’uomo non c’è rischio maggiore che quello di agire senza un significato, cioè senza un orizzonte culturale che sappia reggere il rapporto tra il particolare e l’insieme in cui questo particolare è inserito.
ESPERIENZA LAVORATIVA COME ESPERIENZA AFFETTIVA
L’esperienza mi dice che, con la mia storia personale impregnata di letizia e di contraddizioni, di amicizia e di responsabilità, sono intimamente sicuro di essere fatto per la felicità, sono naturalmente desideroso di essere amato. Questa dimensione dell’affettività non può essere estranea al luogo e alla modalità che mi occupa per la maggior parte del mio tempo e che, in modo sempre più responsabile, mi chiede un coinvolgimento razionale. Io credo che non sia possibile agire con lucidità e creatività senza un coinvolgimento affettivo e, in una parola che fa parte della tradizione cristiana, ricco di speranza, cioè di quella ipotesi positiva che dicevamo all’inizio. Ripetendo quello che diceva Pèguy ne Il Portico della Seconda Virtù, «per sperare bisogna essere stati molto felici». [5] È quando censuriamo questa dimensione della nostra natura che la responsabilità, la creatività, la passione e la ragionevolezza vengono meno. Tutto questo viene di conseguenza relegato a una tecnica, una scaltrezza e, quando va bene, a una tradizione. Tutti sanno che una tradizione dipinta sui muri è una buona cura per la smemoratezza, ma certamente non fa innamorare come un incontro reale e appassionato e, nel nostro caso, non può generare quella ipotesi positiva che ti fa vivere il lavoro quotidiano — qualunque esso sia — come la verifica di un amore incontrato carico di una promessa rigeneratrice. Forse qualcuno potrebbe obiettare che sto dimenticando il dato indiscutibile che il lavoro è anche fatica, stanchezza e, a volte, umiliazione. Tutto vero. È anche vero però che possiamo valorizzare il nostro quotidiano quello che Cesare Pavese chiamava il vivere che taglia le gambe. [6] Possiamo valorizzarlo e renderlo nostro solo se non lo separiamo da tutto il resto. Cioè lo teniamo dentro l’orizzonte della nostra sfera affettiva, come un’occasione data. Come per gli operai di questa bella poesia di Charles Pèguy. [7]
Un tempo gli operai non erano servi.
Lavoravano.
Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore.
La gamba di una sedia doveva essere ben fatta.
Era naturale, era inteso. Era un primato.
Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in
modo proporzionale al salario.
Non doveva essere ben fatta per il padrone,
né per gli intenditori, né per i clienti del padrone.
Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura.
Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza,
una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia
fosse ben fatta.
E ogni parte della sedia fosse ben fatta.
E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con
la medesima perfezione delle parti che si vedevano.
Secondo lo stesso principio delle cattedrali.
E sono solo io — io ormai così imbastardito — a farla adesso tanto lunga.
Per loro, in loro non c’era neppure l’ombra di una riflessione.
Il lavoro stava là. Si lavorava bene.
Non si trattava di essere visti o di non essere visti.
Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.
PER APPROFONDIRE
[1] Non rimanete sulla porta, non bloccate l’atrio, perché quello che si farà male, sarà colui che ha cercato di impedirci l’ingresso, c’è una battaglia fuori, e sta infuriando. Presto scuoterà le vostre finestre e farà tremare i vostri muri, perché i tempi stanno cambiando. Bob Dylan: The times, they are a changing — 1963. Bob Dylan, Blues Ballate, Canzoni — Newton Compton Editori — 1987
[2] Luigi Giussani: Dall’utopia alla presenza 1975-1978 —BUR Rizzoli — 2006
[3] Emmanuel Mounier: Lettere sul dolore — Rizzoli — 2011
[4] Berthold Brecht: Poesie — Einaudi — 1977
[5] Charles Péguy: Il portico della seconda virtù — Medusa Edizioni — 2014
[6] Cesare Pavese: Il mestiere di vivere — Einaudi — 2007
[7] Charles Pèguy: Il denaro — Castelvecchi — 2016